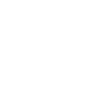Nuovi bioindicatori per la valutazione degli impatti antropici negli ecosistemi acquatici.
- Dettagli
- Categoria: news
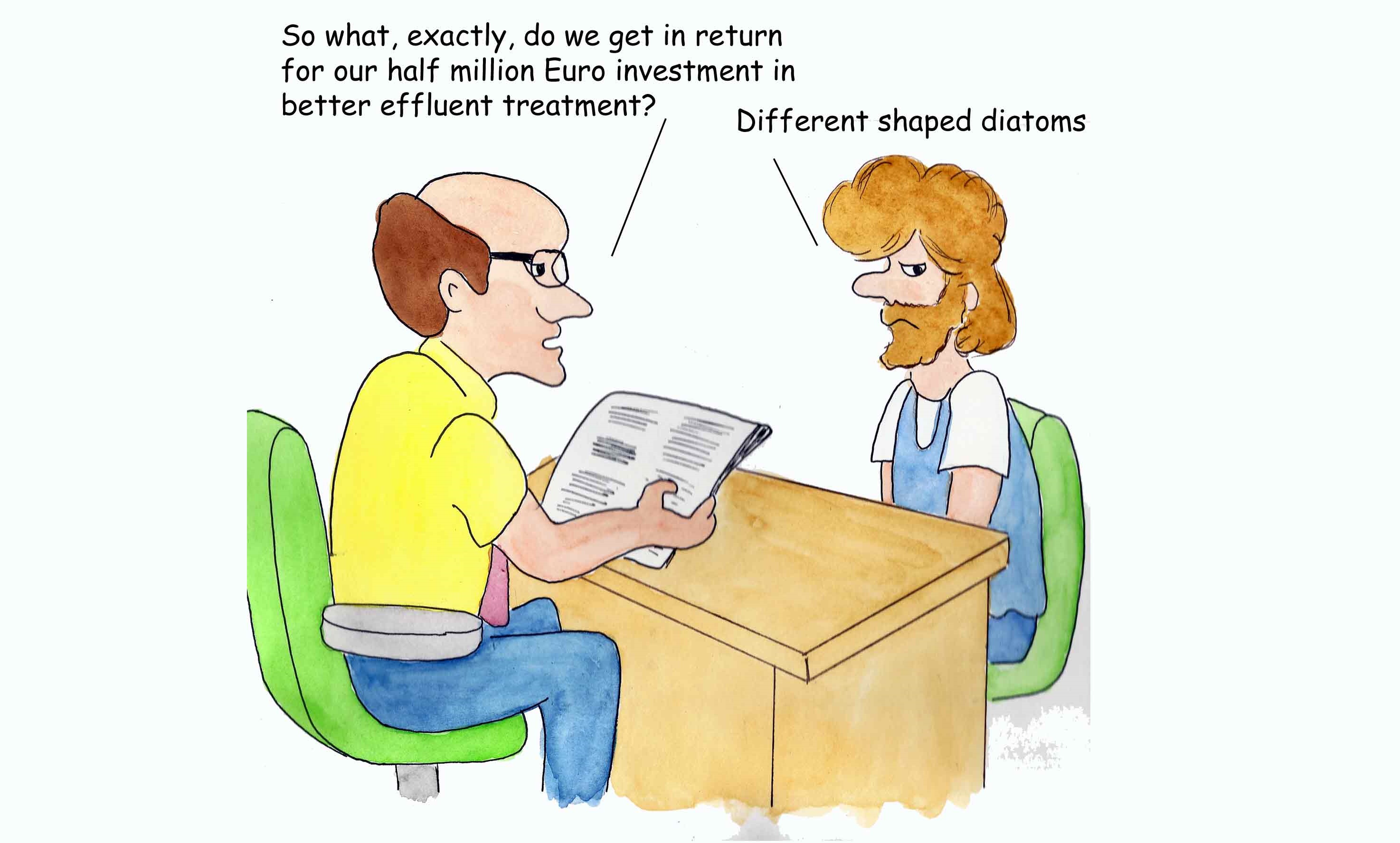
|
La biodiversità negli habitat acquatici sta diminuendo drasticamente come effetto delle attività umane sempre più diffuse. Gli impatti antropici che minacciano la sopravvivenza di habitat e specie sono svariati e spesso non rilevabili utilizzando le metodiche standard. La normativa vigente a livello europeo si basa primariamente sulla valutazione delle comunità biotica per misura dello stato ecologico. Quasi tutti gli indicatori che si utilizzano al giorno d’oggi sono stati sviluppati sulla base della risposta a singoli gradienti, tipicamente gradienti di inquinamento. Diversi studi hanno dimostrato che praticamente tutti gli Elementi di Qualità Biologica (diatomee, macrofite, macroinvertebrati, pesci) sono in grado di rispondere a inquinamenti di tipo organico o di eutrofizzazione. D’altra parte invece, gli indicatori e le metriche in grado di rilevare gli impatti idromorfologici sono molto più rari. In particolare, i macroinvertebrati sembrano particolarmente insensibili alle variazioni idromorfologiche forse perché la scala spaziale e temporale a cui rispondono è diversa da quella modificata dall’impatto (p.e. Friberg et al. 2009). Le nuove frontiere del biomonitoraggio stanno sperimentando nuovi approcci per tentare di affrontare queste nuove sfide. Tra le alternative più promettenti ci sono i metodi che utilizzano le caratteristiche delle specie (species traits). Il vantaggio è che i traits permettono di comprendere direttamente il legame funzionale tra l’ambiente e la comunità (Menezes et al 2010). Per esempio, i macroinvertebrati possono essere classificati in base alla loro propensità ad essere predati dai pesci, e quindi una variazione a carico dell’ittiofauna determina un impatto anche sulla comunità di macroinvertebrati. Un altro esempio di utilizzo dei traits ma con le alghe utilizza le diverse forme di crescita, la capacità di fissare l’azoto e la formazione di spore per rivelare diversi impatti antropici tra cui la diminuzione della portata (Lange et al 2016). Un biomonitoraggio efficacie in grado di rilevare impatti antropici diversi dall’inquinamento-eutrofizzazione richiede un approccio diverso e una più stretta collaborazione tra scienza e applicazione. Il rischio è di causare danni severi all’ambiente senza riconoscerne gli effetti reali. Lange, K., Townsend, C. R., & Matthaei, C. D. (2016). A trait‐based framework for stream algal communities. Ecology and evolution, 6(1), 23-36. Friberg N, Sandin L, Pedersen ML. Assessing impacts of hydromorphological degradation on macroinvertebrate indicators in rivers: examples, constraints and outlook. Integr Environ Assess Manage 2009, 5:86–96. Menezes S, Baird DJ, Soares A. Beyond taxonomy: a review of macroinvertebrate trait-based community descriptors as tools for freshwater biomonitoring. J Appl Ecol 2010, 47:711–719. Poikane, S., Kelly, M., & Cantonati, M. (2016). Benthic algal assessment of ecological status in European lakes and rivers: Challenges and opportunities. Science of the Total Environment 568: 603–613 |
Valutazione e modellazione degli habitat fluviali mediante metodologia mesoHABSIM
- Dettagli
- Categoria: news

| Tra il 2 e il 5 maggio 2016, Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Ateneo di Trento (in particolare il GIAMT, Gruppo di Idraulica Ambientale e Morfodinamica), L'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA Trento), l'Università di Southampton (International Centre for Ecohydraulics Research), il Politecnico di Torino (Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture) e l'ISPRA, (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) hanno organizzato un corso di formazione riguardante la metodologia mesoHABSIM. La metodologia mesoHABSIM si focalizza sullo studio della disponibilità di habitat per la fauna in ambienti fluviali e torrentizi e, a seguito di una consistente applicazione nell’Italia Centro-Settentrionale, si è dimostrata idonea per la quantificazione e la modulazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV), il monitoraggio dei rilasci e delle operazioni di svaso da opere di presa, la progettazione ed il monitoraggio di progetti di riqualificazione fluviale, la stima della vocazionalità ittica di un corso d’acqua, la conservazione di particolari specie acquatiche protette, il calcolo dell'indice di integrità spazio-temporale dell’habitat fluviale (IH). Ai partecipanti (19, provenienti da tutta Italia), sono state fornite le conoscenze per la raccolta dei dati di campo e per l’esecuzione delle analisi di valutazione e modellazione dell'habitat fluviale mediante l'utilizzo dei software MAP-STREAM e SIM-STREAM sviluppati per l'applicazione della metodologia e operanti in ambiente QuantumGIS. |
Disciplina per l'attuazione del rilascio del DMV
- Dettagli
- Categoria: news

| Con la delibera 2378 del 18 dicembre 2015 la Provincia Autonoma di Trento stabilisce che entro il 31 dicembre 2016 tutti i concessionari e titolari di derivazioni d'acqua che non erano mai stati assoggettati alla disciplina del rilascio del deflusso minimo vitale - oltre 1500 piccole derivazioni sparse su tutto il territorio - saranno tenuti a farlo: il limite fissato è di 2 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino. L’eventuale aggiornamento dei valori di DMV sarà effettuato sulla base dei dati derivanti dai monitoraggi svolti sui relativi corpi idrici - per un periodo di almeno tre anni – e potrà essere aumentato fino al valore massimo indicato dalla predetta cartografia del PGUAP. I monitoraggi saranno quelli svolti ordinariamente dall’Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente; tuttavia, nei casi in cui i rilasci insistano su corpi idrici non monitorati ma aventi un’incidenza rilevante sullo stato quali/quantitativo dei corpi idrici, potranno essere prescritti al concessionario monitoraggi integrativi. Nel caso di derivazioni esistenti alla data di approvazione del provvedimento (18/12/2015) non già assoggettate al rilascio del DMV nei valori uguali o superiori a quelli previsti dal PGUAP e per le quali sia stato richiesto il rinnovo del titolo a derivare, esse sono tenute ad effettuare preventivamente la procedura di verifica di assoggettabilità / valutazione dell’impatto ambientale. Con lo stesso provvedimento si stabilisce la cessazione della sospensione dei procedimenti finalizzati al rinnovo delle concessioni idroelettriche con potenza nominale media compresa tra 220 kW e 3.000 kW. |
Valutazione dell'impatto biologico sui laghi alpini provocato dallo sfruttamento idroelettrico
- Dettagli
- Categoria: news

|
I laghi d'alta quota utilizzati per la produzione idroelettrica costituiscono da una parte una importante risorsa di energia rinnovabile e dall'altra un valore ecologico per la biodiversità ospitata. Con l'obiettivo di valutare l'effetto dell'utilizzo idroelettrico sulla biodiversità dei laghi alpini, è stato condotto uno studio su 18 laghi del Trentino ad una quota superiore ai 2000 m. La metà di questi laghi furono utilizzati ai fini idroelettrici tra gli anni '50 e '90 (attività successivamente abbandonata), mentre nove, completamente naturali, sono stati utilizzati per confronto. Per ottenere un'informazione dettagliata sono stati esaminati diversi gruppi biologici, fitoplancton, zooplancton, diatomee litorali, pesci ed è stata eseguita un'accurata indagine bibliografica storica. Ne è emerso che anche a distanza di anni dal cessato utilizzo idroelettrico, alcuni gruppi biologici dei laghi sfruttati differivano significativamente dai laghi naturali. In particolare sono stati i popolamenti litorali (diatomee e benthos) che hanno subito l'impatto maggiore, mentre gli organismi planctonici (fitoplancton e zooplancton) non differivano significativamente tra i due gruppi di laghi. L'impatto sull'ittiofauna è risultato di difficile comprensione a causa delle ripetute immissioni negli anni. Questo studio ha dimostrato l'effetto ecologico dello sfruttamento idroelettrico e ha sottolineato la possibilità che alcuni di questi effetti siano irreversibili anche dopo il cessato utilizzo. L'articolo completo intitolato Comparison between natural and impacted Alpine lakes six years after hydropower exploitation has ceased è stato bubblicato sulla rivista peer reviewed Biologia a nome degli autori Spitale D., Angeli N., Lencioni V., Tolotti M., Cantonati M. L'articolo completo può essere scaricato qui, oppure richiesto agli autori |
Presentato un modello predittivo per la presenza di una specie di muschio rara dell’Allegato II della Direttiva Habitat.
- Dettagli
- Categoria: news

|
Buxbaumia viridis è un muschio raro che ha una distribuzione sporadica in habitat montani dell'emisfero boreale, dall'Asia sud orientale al Nord America occidentale. In Europa è elencata in numerose Red List nazionali e la specie è compresa nell'Allegato II della Direttiva Habitat. Pertanto, essendo specie di interesse comunitario, la sua conservazione richiederebbe la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). E’ una specie che preferisce legno in avanzato stato di decomposizione in boschi freschi e umidi. La presenza di Buxbaumia viridis in Alto Adige era quasi completamente sconosciuta, essendo questa basata su tre soli dati storici. Nell’ambito del progetto "Valutazione dell’integrità degli ambienti forestali altoatesini mediante l’analisi delle briofite", finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano (Ripartizione Diritto allo studio, Università e Ricerca scientifica), è stato condotto uno studio specifico per aggiornare la distribuzione della specie in provincia e studiarne l’ecologia. Il lavoro ha permesso di accertare la presenza della specie in 14 siti identificandone anche la sua nicchia ecologica. La distribuzione della specie in provincia, limitata ai boschi di conifere (prevalentemente peccete), è determinata dalla piovosità nel sito, l’esposizione, la canopy forestale e la quantità di legno morto. In particolare, la probabilità di trovare la specie in boschi con meno di 10 m3/ha di legno morto è molto bassa (intorno al 5 %), mentre se questa supera i 30 m3/ha la probabilità sale a oltre il 60 %. Questo risultato conferma che la specie può essere utilizzata come bioindicatore di un modello silvicolturale che mira alla funzionalità dell’ecosistema forestale. Lavoro pubblicato su Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology |